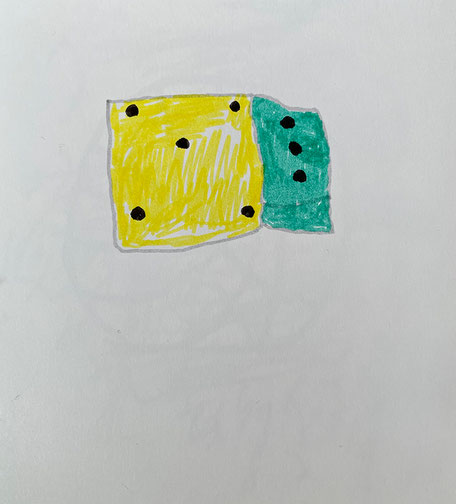Senso
Samira Guadagnuolo per WARSHADFILM
n°5, giugno 2021
Se “bordeggiare” è un processo di navigazione a zig-zag, mi si figura l’immagine di un viaggio incerto, la rottura di un percorso lineare, quello classico da A a B.
Penso ad un percorso intorno al globo che conduce sempre al punto di partenza.
E a ciò che ha detto Michel Mafessoli - che il nomadismo (l’andare continuo e infinito) è l’unica condizione possibile dell’uomo post-moderno - poiché il desiderio di vagare è uno dei poli indispensabili di qualsiasi struttura sociale.
Un procedere nel mondo che segue vortici di vento lunatico, senza un fine se non quello essenziale.
E cos’è quest’unico desiderio possibile e fondamentale?
Quel desiderio che spinge a cercare un altrove che si sposta continuamente, punto indecifrabile della mappa, che costringe a cambiare rotta e procedere per tentativi, e che rinnova sempre la sua fascinazione?
Un meccanismo vitale, che oppone il suo movimento alla staticità della morte.
Una mancanza primaria, la nostalgia essenziale di una condizione di libertà assoluta, che è avvenuta in un tempo prima del tempo, all’alba del mondo, prima della storia.[1]
E che coincide con l’evento stra-ordinario della nascita, del nuovo inizio, del momento stupefacente del cambio di paradigma, del calendario che ricomincia e quindi coincide con la rottura di ciò che è vecchio e con la ri-fondazione del nuovo.
Una rottura che è unica condizione del vedere.
Possibile a patto di non permettere che diventi di nuovo una strada maestra.
Un serpeggìo intorno al senso - senso come organo di apprensione immediata del sensibile - e senso come significato, idea, universale - assoluta conoscenza e libertà.
E allora le qualità sensibili delle nostre “pratiche artistiche”, il loro senso, sono il nostro bordeggiare a zig zag.
“E’ vero che [quel mondo] è passato irrevocabilmente, ma il suo pregio lo sento ora, vale a dire lo comprendo ora, lo amo e infine lo posseggo”, Lalla Romano, da un’intervista.
[1]Nell’infanzia del mondo e per traslazione, nell’infanzia personale vera e immaginaria
Memoria come resistenza ?
Alessandro Rolandi
n°5, giugno 2021
Un lungo racconto, questo di Alessandnro Rolandi, tra oriente ed occidente, a cavallo di una memoria con la “m” minuscola, ma intesa come possibilità. Il disegno, incrociandosi alla scrittura, agisce da rivelatore e, percorrendo il tempo dà corpo a una distanza attraverso cui cercare il senso di ciò che si fa.
“Ho vissuto I primi trent’anni di vita in occidente, tra Italia, Spagna, Francia ed Europa e gli altri venti in oriente, in Cina. L’anno zero del Covid19 -ormai quasi due in realtà-mi ha costretto a rimanere sospeso senza avere alcuna certezza o proiezione su quale parte del mondo sarà la mia prossima base di riferimento. Dalla Svizzera, che mi ha accolto da poco tempo, riesco ogni tanto a tentare di riorganizzare, pur vagamente, i pensieri, mentre le sensazioni e le risposte inconsce del mio corpo e della mia mente sono in una fase di iperattività incontrollabile, in cui, flashbacks, ricordi, paranoie e pulsioni note e sconosciute scaturiscono con violenza inattesa, si intrecciano, si sovrappongono, si combattono, si fondono, si annullano e si nutrono senza alcuna traccia di un pattern, di una logica anche parziale (…)
Allora ho provato a scegliere un angolo di accesso su cui concentrarmi che fosse pertinente al contesto e potesse in qualche modo avere senso per navigare in questo momento. Ho deciso di pensare al concetto di memoria e di farlo cercando di cogliere i cambiamenti e le trasformazioni più importanti avvenute attraverso l’esperienza di una vita adulta in una cultura diversa non “scelta” ma “trovata” e quella di una gioventù in cui, come tutti, sono venuto al mondo dove è successo (…)
Questi quaderni di seconda elementare sono la mia foresta di Junger in cui mi spingo da solo come Waldgänger, e questo testo è un atto d’amicizia verso chi me lo ha chiesto, con cui spero di bere un bicchiere presto e partecipare ad una “mostra” di gruppo.
I disegni sono gli scarabocchi di un vecchio taoista bambino che forse un giorno svanirà nella nebbia delle montagne e non si saprà se sia mai esistito. In tutto questo non c’è contraddizione, ma possibilità, ci si scordano le domande le cui risposte sono troppo difficili, e la memoria-residuo forse diventa resistenza.
Ai margini di una riflessione
Susanna Baumgartner
n°5, giugno 2021
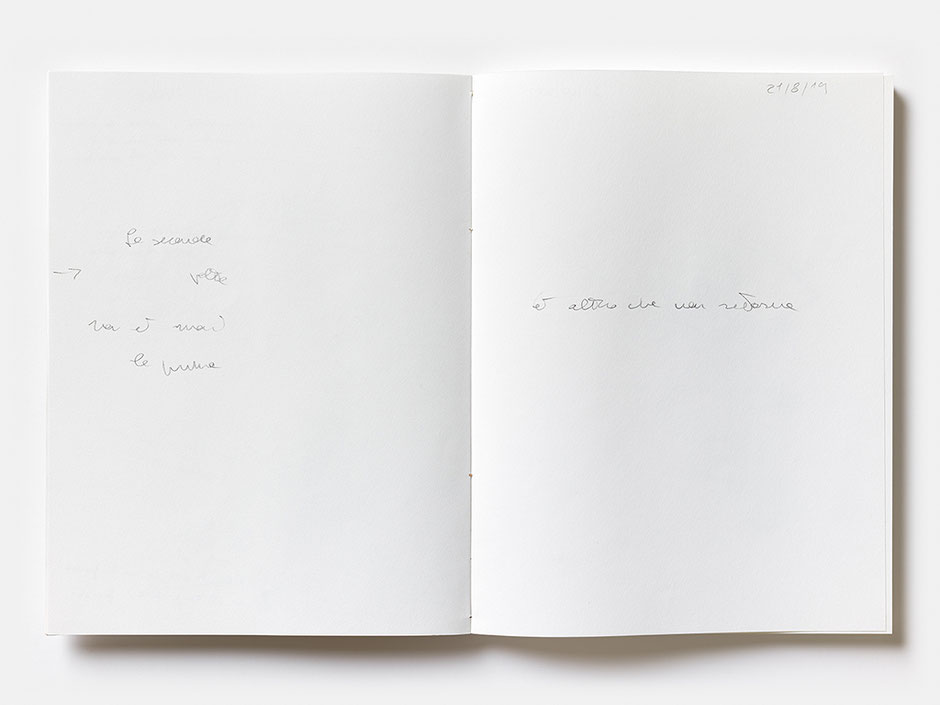
Foto di Alessandro Zambianchi
Ho deciso di inviare due pagine confinanti ai margini di una riflessione.
Nella pagina precedente a queste, nel quaderno di lavoro che testimonia il progetto Scambiare tempo, dialogando tra parole e immagini, c'era questa frase: "vorrei tornare ad essere come il quadro di Casorati ".
Il quadro in questione era: Ragazza sul tappeto rosso del 1912.
Bordeggiare lungo i bordi
Luciano Crespi
n°5, giugno 2021
Non è un gioco con le parole, ma un’avventura del pensiero. Vivere e operare bordeggiando significa mettersi in una posizione scomoda. Bordeggiare vuol dire andare di bolina, una sfida che sembra paradossale. Andare controcorrente è un’impresa muscolare. Essere resilienti – non se ne può più dell’abuso di questo termine, che si studiava per l’esame di chimica – è un atto di volontà, che si fonda sulla capacità di fronteggiare le difficoltà. Lasciarsi andare alla deriva, nel senso indicato da Guy Debord, è una “Maniera più generale di prendere la vita” imparentata con la flânerie. Andare di bolina significa in un certo senso recuperare la métis, essere più astuti del vento, trovare l’angolo giusto per riuscire a procedere anche se il vento ti soffia contro. Quasi una violazione delle leggi della fisica.
Bordeggiare lungo i bordi è impresa estrema. Che aggiunge alla durezza del compito la deliberata insensatezza di viaggiare in un territorio circoscritto, perlustrare un orlo, un margine, dove la navigazione rischia continuamente di schiantarsi contro le sponde che la delimitano o di sembrare imprigionata da forze inaudite. Quasi come ciò che accade all’interno dell’orizzonte degli eventi, quella superficie immaginaria che circonda ogni buco nero e per sfuggire alla quale occorrerebbe avere una velocità di fuga superiore alla velocità della luce. E che dunque possiamo considerare come una zona superata la quale non è più possibile, neanche per la luce, fare ritorno. Eppure, è proprio lungo quei bordi che possono accadere le cose più impensate, capaci di sovvertire “l’ordine del discorso”. Anche per ciò che riguarda gli statuti disciplinari. Pensiamo al mondo in cui siamo immersi, un mondo sempre più disseminato di avanzi, luoghi che hanno smesso di svolgere la funzione per la quale sono stati realizzati. E che ora si trovano come in uno stato di sospensione e attesa. Cosa ne facciamo? Li abbattiamo? Li conserviamo come malinconiche testimonianze da offrire al consumo avido degli amanti dello splatter? E se invece, in un secolo caratterizzato dalla diffusione planetaria del neonomadismo, delle migrazioni e della precarietà, provassimo a riscattarli dal loro destino altrimenti atopico trasformandoli in luoghi da destinare a funzioni provvisorie, nate da domande, spesso imprevedibili, di cambiamento dei modi d’uso degli spazi?
È qui che entra in gioco la necessità di una revisione di statuto disciplinare e di stile di pensiero. Bordeggiando. Introducendo un nuovo approccio progettuale, fondato sull’idea di accogliere nel progetto come un “dono” gli elementi di degrado presenti nell’avanzo, per tradurli in una sintassi finalizzata a realizzare rifugi per i neonomadi del terzo millennio. L’ho definito design del non-finito, come disciplina di confine, collocata tra design, interior design, arti, restauro, exhibition design, scenografia, cinema, il cui obiettivo è di inventare una “nuova tradizione”, fondata su ciò che si potrebbe definire “estetica dell’avanzo”, che rinuncia all’immagine levigata per dare forma all’incompiuto, all’inaudito, all’impensato.
Stitching the Border
Elisa Vladilo
n°4, maggio 2021
Stitching the Border, 2010, nastri e picchetti, Monte Sabotino (Gorizia / Nova Gorica - Italia/Slovenia), 150x150 cm ognuno
Quando abbiamo iniziato a parlare del progetto Separazioni, pensando alle linee di confine dei tre paesi coinvolti nel progetto, Austria, Italia, Slovenia, ho subito pensato che in realtà questi confini è come se non ci fossero più. Negli ultimi anni, progressivamente sono state eliminate le frontiere tra diversi paesi europei, e introdotta la moneta unica, favorendo lo scambio sia di merci e la libera circolazione, anche tra i paesi sopracitati.
In questo modo le linee di confine è come se avessero perso parte del loro significato e della loro funzione, poiché se in passato poteva essere più problematico oltrepassarle, adesso non lo è più, e restano semplicemente a simboleggiare il limite di un territorio, cioè una separazione tra un paese e l’altro, contenente culture, lingue, e costumi diversi tra loro.
Le zone di confine, sono comunque sempre un’area di sfumatura, nel senso che qui si trova facilmente una commistione tra le due diverse nazionalità.
Pensando a questo confine che c’è e non c’è allo stesso tempo, mi sono vista una specie di “cucitura” sulle linee di confine, una ricucitura dei territori, una riunificazione più effettiva e profonda, nel rispetto delle identità, riportando cosi la terra all’unità originaria, frazionata dagli uomini nel corso del tempo, e che negli ultimi anni pare stiano riunendo. La cucitura me la immagino fatta a punti incrociati, grandi, colorati con toni caldi, arancio, rosa e giallo; una cucitura ironica, ludica, allegra, sdrammatizzante, propiziatoria ad una felice coesistenza.
Sbordi e macchie marginali
Per una deriva centripeta
Gianluca Codeghini
n°4, maggio 2021
A sollecitarmi nel raccontare questo gioco non è stato tanto il divertimento che ho provato nel giocarlo la prima volta e nemmeno le dinamiche che innesca tra i giocatori, ma la sua congenita ambiguità, tale da renderlo uno dei giochi più “alla deriva” di sempre. Ma deriva di cosa? Dove si spinge il suo margine, e tra cosa? Non è forse questo gioco una forzatura impressa a livello sociale per creare ed evidenziare delle differenze tra ciò che è e che deve restare al centro e ciò che invece deve restarne fuori? Sbordi e macchie marginali contribuisce sicuramente a questo confinamento forzato e a questa pretestuosa ambiguità, in cui restare ai margini significa essere in una posizione di limite, o di confine, certo a volte una condizione di merito, ma anche di demerito, ovvero un privilegio e insieme una via di fuga, che tuttavia esistono perché persistono e sono regolati da una anomalia.
Il fenomeno fa molto pensare, perché è fondato su un giudizio già accreditato: lo stesso collante con cui un sistema autoreferenziale riesce a sopravvivere assicurandosi dei margini di profitto. Ma Sbordi e macchie marginali non è soltanto questo, e lo capirete giocando.
La premessa è propedeutica alla produzione di una scelta da parte del giocatore, che risulterà strategica nella successiva pratica di gioco. La determinazione di cosa è bordo è dunque la prima delle regole per poter definire la propria strategia nella sua singolarità, anomalia o alterità. A questo punto è tutto meno ambiguo e il giocatore, emarginato dallo stesso gioco, impedito di mettersi in gioco perché per definizione già parte di una matrice di opposti, può giocarsela in solitaria. Così facendo, forse, con questo adoperarsi nel conoscere il proprio bordo e nel dominare la propria deriva, avrà maggiori chance e per lui sarà più semplice riappropriarsi di un proprio spazio di manovra e di “libertà” nel creare nuovi bordi.
Nella regolarità del proprio bordo – che lascia tutto fuori, perché esiste nella dualità non palesata non del dentro/fuori ma del fuori/fuori – lo scopo del gioco è allora questo. Appare sempre più chiaro che esso non è tanto per una strategia del movimento ma di movimento nel movimento: aleatorio, inedito e privo di sostegno, nel segno del sospetto, così da agevolare e spostare l'inquadratura scelta al punto tale da lasciare nella memoria il dubbio di averla macchiata o di non averla macchiata affatto.
1845
Pantani e Surace
n°4, maggio 2021
Un’edizione non autorizzata de I promessi sposi di Alessandro Manzoni, capolavoro della letteratura italiana dell’Ottocento, la storia dei diritti d’autore e quella della Santa Reparata si intrecciano in un lavoro che attraversa il tempo e cresce tra le mura della sede della storica Libreria Le Monnier.
Una serie di cause legali che videro lo scrittore milanese, Manzoni, nelle vesti di avvocato per la tutela del diritto d’autore, in una vicenda che durò per oltre venti anni, vinse tutti e tre i gradi di giudizio creando così il fondamento giuridico al diritto d’autore in Italia e in Europa.
Dopo quasi duecento anni il frontespizio dell’edizione contestata torna a generare nuovi significati.
1845, 2019, xilografia su linoleum stampata su carta bianca 80 gr, 187x132 cm, SRISA Gallery-Santa Reparata International School of Art Firenze, a cura di Pietro Gaglianò, foto archivio Pantani-Surace
Un appunto
Aurelio Andrighetto
n° 3, aprile 2021
In Combray (Dalla parte di Swann), Marcel Proust sovrappone il volto della Giustizia dipinta da Giotto a quello di certe bigotte di Combray “arruolate da un pezzo nelle milizie di riserva dell’Ingiustizia”. La Giustizia si sovrappone all'Ingiustizia con una symmetria che conferisce all’intreccio complesso di immagini, parole, concetti, percezioni ed emozioni una forma sintetica e perfetta.
Leggendo il passo penso che solo nella scrittura l'immagine può trovare una sua corretta posizione rispetto a questo intreccio che chiamiamo pensiero. Tuttavia Proust osserva che nell’affresco giottesco l'immagine è un simbolo materializzato: l’immagine della Giustizia ha cioè un lato rivolto verso il reale, ha una concretezza senza la quale non sarebbe stato possibile riferire il suo viso a quello delle bigotte di Combray e dare così corso al suo pensiero. Perciò mi ricredo.
Non è nella scrittura, ma sul confine tra il viso dipinto da Giotto e quello rievocato da Proust che il pensiero si muove e poi prende forma, diventando la Recherche o la Iustitia dipinta sulla parete destra della Cappella degli Scrovegni. Prende forma solida qualcosa che non è solido. Tra la solidità della forma scritta e quella della forma dipinta sta qualcosa di liquido, o gassoso, o fluido, che la pittura di Giotto e la scrittura di Proust arrestano.
Tra le due c'è un "infra", una pausa, un vuoto come quelli che si aprono improvvisamente nelle attese. In questi vuoti il pensiero è allo stato fluido, non ha una forma. Quando la prenderà non sarà più pensiero ma una sua espressione.
Sulla natura pulviscolare
Collettivo DAMP
n° 3, aprile 2021
Grande Raccordo Anulare
Gaia Bobò
n° 3, aprile 2021
La dimensione del bordeggiare, o forse più propriamente quella del costeggiare, appare oggi come una suggestione utile ad evocare la necessità di rileggere in una nuova prospettiva i sistemi della società che viviamo. Nel tempo sospeso della pandemia abbiamo assistito, e ancora assistiamo, allo stravolgimento delle prassi relazionali che caratterizzano la nostra quotidianità, nonché del modo stesso in cui i nostri corpi abitano lo spazio. Il susseguirsi di chiusure e limitazioni che ha portato al collasso del sistema culturale, determinando la messa in crisi di una struttura già precaria, ha reso altresì necessario un ripensamento dei paradigmi dominanti che per decenni ne hanno regolato gli equilibri. Inevitabile l’accelerato rovesciamento della dialettica centro-periferia, e così della messa in discussione degli stessi concetti di centralità, marginalità, funzionalità. Le zone di confine, i margini, i bordi, appunto, non solo in termini urbanistici ma anche in quanto esperienze al latere dei sistemi ufficiali, si sono costituiti paradossalmente come unico spiraglio possibile attraverso cui continuare a esistere. Si è resa allora necessaria una riflessione su come abitare questi margini, ovvero non semplicemente come delle isole, ma intendendoli come connettori, spazi indefiniti attivati da un movimento perpetuo.
L’immagine di un moto continuo, irregolare e circolare, che autobiograficamente associo allo spazio del Grande Raccordo Anulare - tratto autostradale che abbraccia la città di Roma come un moderno e caotico pomerio asfaltato- riflette forse la necessità di questi mesi di continuare ad operare reiterando uno schema comportamentale utopico, fatto di atti inutili, in cui il movimento è strumento di sopravvivenza e auto-rappresentazione. Un’azione che si rende necessaria, dunque, in quanto disfunzionale, e che per questo trova un legame profondo con lo stesso fare artistico.
Parlo di Roma, inevitabilmente, non solo per raccontare uno spazio in cui vivo, ma anche per restituire l’immagine di una città che proprio nel contesto della crisi pandemica ha simbolicamente visto rifiorire i suoi margini proprio grazie alla nascita di aggregazioni artistiche spontanee, portate avanti prevalentemente da realtà indipendenti e di ricerca, a cui io stessa appartengo. E forse, proprio per questo, mi inserisco in questo dialettico piano gassoso con lo sguardo di chi “pratica il margine” come missione quotidiana, poiché in questo trovo l’espletamento di una funzione apotropaica, una scaramantica danza che, mi auguro, non porti a piovere di nuovo sul bagnato.
Orizzonte antidemocratico
Gabriele Jardini
n° 3, aprile 2021
Orizzonte, 2011, stampa fotografica, 127 x 178 cm
Diversi miei lavori sono piuttosto “antidemocratici” verso l'osservatore perché l'intento è sempre quello di convogliare lo sguardo di chi osserva in un punto preciso dell'immagine, in questo caso sul bordo del tavolo; da qui il titolo Orizzonte . Tutte le volte che si osservano gli innumerevoli oggetti presenti, compressi per una sorta di illusionismo ottico, l'occhio dell'osservatore, pur perdendosi su tutta la superficie interna, viene sempre spinto con decisione sulla linea dell'orizzonte, il bordo del tavolo. Il bordo qui ,come nella barca, è sia esterno che interno, oltre il quale vi sarebbe un crollo di senso, la nave affonderebbe.
Lo studiolo dove dipingo
Stefano Peroli
n° 2, aprile 2021
Caro Ermanno,
voglio descriverti il mio studiolo 5x3 dove dipingo, dirti perché riesco a dipingere al suo interno. E’ un luogo luminoso, il sole entra dal primo mattino fino al tardo pomeriggio e alla mia età la luce naturale è uno dei beni più preziosi per dipingere, o anche solo per pensare il dipingere. Lavoro a un tavolo a ridosso di una parete bianca, piastrellata e con l’ausilio di una tavola di legno, sulla quale applico la tela, dipingo sia seduto che in piedi. Nel corso degli anni ho costruito una valigetta di legno per tenere dentro tutto: pochi tubetti di colori ad olio (riesco a non finirli mai), tre pennelli piccoli e piatti, qualche straccio, una spatola, una decina di matite (eterne), puntine, due squadrette, una forbice, un paio di guanti irrigiditi dal colore, una scodella di vetro per l’olio di lino, due pennelli induriti che non uso da anni. Quando finisco di dipingere ripongo tutto nella valigetta e imbosco la tela lontano dallo sguardo. Trascorro i pomeriggi, poche ore, mezz’ora, qualche minuto a questa postazione, davanti al quadrato della tela; alle mie spalle il lavandino e la lavatrice con tutti i pensili, forno, fornelli e frigorifero. Il sole entra dalla mia sinistra.
Il mio studiolo è la cucina. La cucina, nell’appartamento in cui vivo con Patrizia, è lo studiolo. E’ lo studio più giusto che abbia mai avuto e riesco a dialogare con i miei quadri indisturbato. Il tempo che conta è esclusivamente lo spazio del mio corpo che fa corpo con la tela. Sul lato fornelli ci sono delle foto appese. Una, a me molto cara, delle Grigne e del Resegone, scattata dalla periferia nord di Milano; il Ritratto di Vollard di Picasso; alcune opere di Robert Motherwell, con una sua immagine di spalle mentre dipinge; il poster di una mostra di Osvaldo Licini; la Pietà Rondanini; John Cage; Primo Levi; Pier Paolo Pasolini; Zeno Birolli; Liliana Segre. C’è anche un breve testo del giovane Gastone Novelli, scritto dal carcere di Regina Coeli.
E’ qui che continua a morire il mio amore per la pittura, per questo gesto insopprimibile, ma inutile, che si arresta in quei miei corpi un po’ raffazzonati, attesi da tantissimi anni. Mi sento in un antico cantiere che da sempre svanisce dentro di noi. Ben distante da distrazioni e speculazioni, non ho più la pretesa di sapere perché io dipinga. Tutto finirà e credo che la pittura mi dia solo un po’ di coraggio.
Nello studiolo, immerso in un fiducioso dialogo con l’opera, cerco di incontrare il volto stesso del dipinto. Non appendo niente, non viene appeso nulla. Per me, del resto, anche appendere un quadro in pubblico ha sempre rappresentato un gesto privo di dignità. Dopo svariati secoli dipingo ancora un corpo, vivo e morto, sospeso nella tela, sorretto dal proprio vuoto, che mi dica se è ancora plausibile essere lì, ma esso non me lo dice. E’ ancora possibile crederci? No, non lo è più e con l’età, se posso, cerco di crederci sempre meno.
E’ per questo che provo ancora a dipingere, libero e deresponsabilizzato dalla pittura stessa, dal suo vuoto, riuscendo a farlo in questa cucina, studiolo, cella. Dalla porta-finestra di questo spazio che dà su un balcone, ogni giorno vedo la Terra e quel che è certo è che non vi farò più ritorno.
Un saluto a te e agli amici.
Dictionaire, Tome Cinquante-Septième, Vid Vie, 2007/2021
Paolo Parisi
n° 2, aprile 2021
Per Virginia Zanetti: tre domande sul guardare
Virginia Zanetti
n° 2, aprile 2021
1) Sopra-Sotto. Sono nozioni riconducibili alla logica binaria con cui ordiniamo e ci “ordiniamo” nel mondo. Il ribaltamento dei termini comporta un rovesciamento dello sguardo e uno smarrimento delle certezze: è il “buio” di un’eticità possibile?
Il rovesciamento è un metodo creativo in ogni ambito, è un moto dinamico, vitale. Le certezze ci rassicurano ma allo stesso tempo fermano la vita, creano stagnazione, in qualche modo sono molto vicine alla morte. La logica binaria serve per pensare la vita, eppure la vita non è binaria, contiene contemporaneamente gli opposti: non esiste il buio senza la luce, morte senza vita, male senza bene. Quindi laddove sembra esserci mancanza di eticità è proprio lì che ci sono le potenzialità per crearla. Serve un ribaltamento del comune modo di pensare tale per cui si passi dal credere che possa esistere solo ciò che è visibile e sperimentabile al credere che possa esistere ciò che immaginiamo. Poi occorre collegare l’azione, ovvero adoperarci perché ciò che è pensato diventi concreto.
Lo stesso vale per il pensiero binario sull’io e l’ambiente: non esistiamo separati dal contesto sociale e naturale. Noi esistiamo al meglio quando capiamo che siamo strettamente connessi a tutto il resto e quindi cooperiamo. La sfida continua è superare la tendenza che ci fa pensare che possiamo esistere disgiunti o addirittura a scapito di tutto il resto. Il buio dell’eticità corrisponde a questa oscurità innata nell’essere umano, quindi occorre un moto attivo per aprire la vita a partire dall’individuo fino ad arrivare ai governi politici, alle organizzazioni mondiali e così via.
2) Di traverso. Attraversando gli opposti sembri descrivere un incedere che riguarda più in generale una trasversalità rispetto ai linguaggi, ai mezzi e alle pratiche dell’arte. Che cosa fai dunque di mestiere?
Prima di tutto sono un essere umano, la trasversalità deriva dalla sete di conoscenza e di ricerca della verità che accomuna ogni essere umano. Come essere umano le mie attitudini principali sono quelle del pensiero creativo e dei linguaggi espressivi artistici, quindi ho coltivato quelle e ne ho fatto anche un mestiere che non ha soluzione di continuità con la mia vita. Ho necessità di seguire diverse vie, incrociarle, ribaltare e sperimentare, quindi si tratta di un mestiere sui generis. Infatti credo di aver compreso che anche se l’arte è creata dall’essere umano, e quindi è considerata un artificio, essa cerca una mimesi con la natura, tenta quindi di avvicinarsi al principio della creazione naturale. Per questo credo che l’arte non sia totalmente controllabile, catalogabile, ripetibile; per quante regole e costanti ci si cerchi di dare o si possano trovare, essa è dinamica come la vita. Nonostante alcune formule siano più felici di altre, l’ispirazione e la creazione non sono mai totalmente sotto il mio controllo. Come l’acqua di un fiume seguo il flusso in continui mutamenti, accolgo i momenti in cui sembra fermarsi l’acqua, scomparendo nel terreno, ed accolgo le esondazioni. È come se mi affidassi liberamente al principio della creazione per poi cercare un minimo di controllo sia con i linguaggi che ho imparato, approfondito, sia cercandone di nuovi, aprendo nuove collaborazioni con altre discipline, affidandomi o creando coralmente un’opera insieme a persone molto diverse tra loro e provenienti da diversi ambiti e contesti.
È pensiero comune che l’artista abbia una particolare vocazione e uno spiccato senso di missione; per quanto mi riguarda è vero, ma è altrettanto vero il fatto che qualsiasi ruolo o posizione si occupi nel mondo dovrebbe esserlo per ognuno. È proprio il senso di missione e il sentirsi lo strumento adeguato per quella cosa che si sta facendo a fare la differenza tra il vivere una vita realizzata o meno.
3) In un tempo sospeso. È come se tu cercassi la forma in uno spazio che non c’è, come per esempio ne I pilastri della terra, dove le dita e la terra si toccano pur rimanendo separati. Si tratta di uno spazio che diventa tempo in stato di arresto. L’intangibilità spazio-temporale è una speranza per la forma?
Ho sempre cercato qualcosa che mi aiutasse a tracciare una strada sia nella mia ricerca che nella mia vita; in generale credo che tutta l’umanità abbia bisogno di una filosofia che le dia una direzione. L’utopia di molte ideologie politiche e il credo di molte religioni hanno cercato da sempre una formula che potesse contribuire al miglioramento della società, questi hanno determinato “opere” e azioni le quali hanno impresso direzioni opposte ai moti storici. Credo siano molto importanti per un’artista la determinazione interiore e la profonda intenzione che modifica la qualità delle proprie azioni; questo incide anche sulla sua condizione vitale e sulle persone che si relazionano con le sue opere. Uno dei pensieri che genera l’opera de I Pilastri della Terra è la potenzialità di ogni singolo essere umano di emanciparsi, perché parte del ritmo dell’universo. Forse il “tempo sospeso” è quell’attimo in cui possiamo percepire il ritmo dell’armonia cosmica di cui facciamo parte, destinato un secondo dopo a mutare e a lasciare un senso di malinconia e di vuoto per ciò che è appena sfuggito. Allo stesso tempo quel vuoto, nel suo bisogno di pienezza, è ciò che genera l’energia necessaria per spingersi ancora una volta a ritrovare quella sospensione, e così via.
La mia ricerca è basata su questo moto e la forma è strettamente legata a ciò che la sostiene, quindi se la forma esprime questa sospensione, allora l’opera è riuscita.
Without public nothing art: storia di una foto
Giovanni Bai
n° 1, marzo 2021
Ai bordi della visione: non ti ho visto nella realtà, ma ti ho visto nella fotografia che ho scattato.
Forse è una leggenda metropolitana, comunque assai verosimile. La storia è raccontata da Lee Friedlander in un manuale di fotografia degli anni settanta: un fotografo scatta delle immagini in occasione di un incidente stradale e quando sviluppa il rullino si rende conto che la vittima è suo padre (a scelta, suo figlio…).
La foto di cui parlo ci rimanda a una situazione differente, ma che riguarda la mediazione tra noi e la realtà che gioca la fotografia e il rapporto tra guardare e vedere. Si tratta di una panoramica di una sala di Palazzo Grassi a Venezia, mostra di Cartier Bresson, fine agosto 2020.
Ho scelto questa immagine in quanto ideale per rappresentare il concetto di "without public nothing art" in occasione dell’intervento di MUSEOTEO+ (da trent’anni ai bordi del sistema dell’arte) per la giornata del Contemporaneo del 2020, e ribadire la posizione su arte on line e arte in presenza. Quando ci definimmo museo senza sede e senza opere era chiaro che nulla aveva a che fare col museo immaginario di Malraux: il nostro era un museo reale, con la gente e le opere, anche se la durata della mostra era effimera.
Probabilmente la foto, che ben rappresenta il rapporto tra opere e pubblico dell’arte, sarebbe rimasta nell’archivio se non si fosse presentata questa occasione. Riguardandola mi sono reso conto che nella foto compaiono due persone che conosco, due amiche, Carolina e Carla. Una al bordo destro della foto e della sala, l’altra dal lato opposto.
Non mi sono stupito che Carolina fosse presente nell’inquadratura, anche se al momento dello scatto non me ne ero reso conto, visto che visitavamo la mostra insieme.
Non sapevo, invece, che anche Carla fosse presente tra i visitatori della mostra. E se non l’avessi casualmente incontrata poco più tardi nel corso della visita (essendo entrata alla mostra prima di noi avrei anche potuto non incontrarla, non sapere che era lì) probabilmente riguardando la foto non l’avrei riconosciuta o, meglio, non mi sarei reso conto che fosse lei. Riguardando la foto ho scorto, tra venti persone, la sua sagoma, di profilo, mentre osserva un’opera: anche lei non mi aveva visto, ma stava guardando le opere, io invece stavo guardando il pubblico…
Se non l’avessi incontrata l’avrei vista? L’avrei riconosciuta nella foto? L’ho vista e riconosciuta perché sapevo che era lì.
Testo per bordi
Roberto Limonta
n° 1, marzo 2021
In principio era l’Azione
(Goethe, Faust)
Si discute di bordi, lembi e altri margini. E se ne discute, va da sé, in termini di spazio: entità minimali e discrete, propaggini di terre esotiche e sconosciute. La metafora del locus, interiore ed esteriore, è comune e sempre utile: indica l’oggetto della discussione, lo fissa e lo definisce (o almeno ci prova), gli dà una dimora, lo rende stanziale. Mi domando se insistere sui margini (nel senso di esserci e starci, frequentarli, oppure “abitarli” se vogliamo heideggereggiare) non ci conduca a ripensare i margini senza la marginalità; ovvero senza fare una necessità della libera contingenza con cui ci muoviamo attorno ai lembi del mondo, senza farne un controsistema che riprodurrà, specularmente, quello dal quale ci teniamo distanti, il cuore pulsante dell’impero. Senza opporre il Margine al Sistema, insomma.
Mi domando quindi se il lembo non sia il rifugio della marginalità, o una sua buona scusa. Per questo diffido del simbolismo spaziale: mi sembra imbrigli la natura nomade che ferve nei bordi e nei lembi, ne faccia appunto qualcosa di stanziale, di concluso e risolto, come una riserva indiana che, nel momento in cui custodisce, spegne poco a poco la scintilla della vita. Per questo proverei a ragionare sui bordi dal punto di vista del tempo: perché lo spazio può essere occupato in forme sempre più precise e pervasive, ma il tempo no, il tempo si dilata verso un futuro infinito e indefinito sul quale la presa è molto relativa. E’ l’idea di uno sguardo che osserva attraverso lo spessore di una distanza, come citava Ermanno nella sua lettera. Quella distanza è ciò che rimane degli atti con cui tracciamo, facendole e disfandole continuamente, le linee di confine dei nostri oggetti, di ciò che sappiamo e di ciò che creiamo, anche dunque di ciò che siamo (come in quel testo di Borges, dove le linee con cui cerchiamo di fissare i confini del mondo disegnano, nel corso degli anni, il volto di chi le ha tracciate). Altrimenti, che differenza ci sarebbe tra bordo e centro? Perché immaginare che le operazioni in un luogo o nell’altro dovrebbero essere radicalmente differenti? E chi decide dove si colloca il bordo, dove e come si profilano i suoi margini? In fondo, non ci sarebbe differenza “nel fare” tra un artista del bordo e uno del centro, tra un apocalittico e un integrato. Non diventerebbe, il lembo, un refugium peccatoris dove il fare è sostituito dal parlarne, nella sua versione peggiore che è quella del lamento sui tempi? Invece ragionare su bordi e lembi offre la possibilità di porsi questioni diverse: a che punto si passa dalla verbalizzazione del margine alla sua pratica? Quando, invece di discutere di arte ai bordi, ci si può porre dalla prospettiva del margine per creare? E cosa potrebbe significare creare opere che siano in sé lembo, solo lembo? E’ possibile una parte senza il suo tutto, il bordo come rifiuto del proprio contenuto, come propria impossibilità?
Per questo il lembo – mi sembra – è tempo più che spazio, è l’operazione con cui fissiamo l’ordine mobile dei confini attorno ai quali ci muoviamo: il confine è sempre una questione di distanza, della giusta distanza da cui guardare le cose per fissarne i contorni. “Bordeggiare”, appunto. Per questo scrivo “mi sembra”, non per un vezzo di malcelata modestia: il lembo appare, prende forma e poi la perde, si riforma in assetti instabili e diversi. E’ azione più che cosa. Più che collocarsi ai margini dello spazio, insomma, più che essere l’estremità, periferia o confine, il bordo è il rifiuto dello spazio: risvolto poetico della definizione, eresia della totalità.
31 gennaio 2021
Speedy Gonzales andata e ritorno
Luca Scarabelli
n° 1, marzo 2021